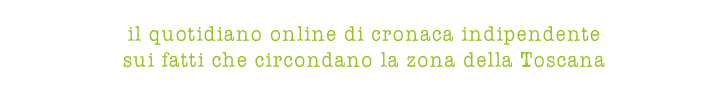“Nascita di una nazione”. Le considerazioni critiche di Nicola Nuti sulla mostra di Palazzo Strozzi.

 La mostra Nascita di una nazione, allestita in Palazzo Strozzi (fino al 22 luglio), s’ inaugura paradossalmente in un’ epoca in cui sembrano svanite quelle istanze culturali e sociopolitiche che avevano fatto ribollire la scena artistica italiana alla fine della seconda guerra mondiale. E forse proprio per questo dislivello epocale si nota maggiormente la parzialità dell’ indagine condotta dal curatore attraverso gli ultimi decenni del secolo appena scorso.
La mostra Nascita di una nazione, allestita in Palazzo Strozzi (fino al 22 luglio), s’ inaugura paradossalmente in un’ epoca in cui sembrano svanite quelle istanze culturali e sociopolitiche che avevano fatto ribollire la scena artistica italiana alla fine della seconda guerra mondiale. E forse proprio per questo dislivello epocale si nota maggiormente la parzialità dell’ indagine condotta dal curatore attraverso gli ultimi decenni del secolo appena scorso.
In realtà non era nata una nazione, ma una democrazia, e una democrazia senza una nazione, cioè un sostrato umano e unito, mostra da subito tutta la sua fragilità. Le divisioni sul piano culturale e ideologico si evidenziarono presto: tra nostalgici novecentisti, realisti e astrattisti, intellettuali zdanovisti e marxisti. Il Partito Comunista aveva emanato un proprio programma in cui arte e politica dovevano essere indissolubilmente uniti, mentre dalla Francia si levava la voce di dissenso di Garaudy: “gli artisti comunisti non sono artisti in uniforme”. Del resto lo stesso Vittorini affermava che “gli intellettuali non devono suonare il piffero per la rivoluzione”. Queste tensioni interne fecero nascere il paradosso per cui l’arte di ricerca, prevalentemente portata avanti da artisti di sinistra, veniva tacciata di elitarismo dagli apparati di partito e quindi quasi messa al bando. Di conseguenza vi fu una profonda frattura tra i diversi gruppi di astrattisti , Forma a Roma, MAC a Milano e Astrattismo classico a Firenze e la schiera di artisti legati al realismo del Fronte nuovo delle arti.
Ora, quello che si percepisce dalla mostra di Palazzo Strozzi è che tutti gli artisti non tradizionalmente figurativi erano dei rivoluzionari e quindi di sinistra (e viceversa), quindi riconosciuti dall’establishment culturale comunista, ma a quanto pare non era così. La loro arte era considerata marginalmente e perlopiù irrisa. Ma gli anni passano, arrivano gli anni Sessanta e il boom economico finanziato dal Piano Marshall. Nel 1966 al Festival di San Remo avevano vinto Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti; l’industria automobilistica aveva visto il suo primo rallentamento di produzione, ma ancora non si parlava di crisi, anzi, i consumi erano in crescita e la televisione non disdegnava di arricchire i palinsesti con argomenti culturali. Quello fu anche l’anno in cui gli Italiani avevano letto di più; gli Oscar Mondadori andavano forte e l’editoria in genere era piuttosto florida. A quel punto si capisce che l’ operaio non lotta più per la rivoluzione, ma per avere la sua Cinquecento, il frigorifero e il televisore; ed emergono i temi dell’alienazione, dell’incomunicabilità, della solitudine, di un’ industrializzazione che impoverisce le campagne e crea desolanti periferie. La politica, almeno quella del Pci, allenta il controllo sull’ arte, che si fa più introspettiva e sperimentale, anche per riaffermare il valore identitario dell’artista alle prese con nuovi concetti spaziali (Fontana, Scheggi, Bonalumi, Castellani, Dadamaino), o con il posizionamento del proprio Io in una società sempre più complessa (Manzoni). Ecco, forse mancava questo passaggio per illustrare bene, come in Italia si arriverà poi alle influenze della Pop art, all’arte povera, al minimalismo.
Una mostra didascalica per il grande pubblico, fatta purtroppo, con i nomi più di mercato, che non approfondisce e che quindi lascia i più, ancora una volta, perplessi di fronte alla Merda d’ artista.
Nicola Nuti