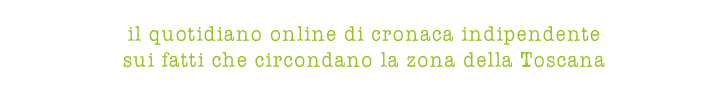Intervista di Vanity Fair a Paul Dybala. (autore Malcom Pagani)

Leggendo Vanity Fair mi è piaciuto questo articolo su Paul Dybala, per me molto interessante di cui ne è autore Malcom Pagani.

Questo articolo è stato estratto dal numero di Vanity Fair in edicola dal 6 dicembre
Ogni volta che sorge il giorno, Paulo si ricorda di quando era notte e si faceva silenzio: «A volte per capire bisogna anche saper tacere. Ascoltare di più e parlare di meno. Io spesso sto zitto, ma è un piacere, non una sofferenza. Mi piace sentire cosa hanno da dire gli altri, formarmi un’opinione, non essere costretto a intervenire per forza».
Dopo tre ore di fotografie, cambi d’abito e consigli che somigliano a ordini: «Sorridi, calcia, palleggia, indossa, cammina, girati», il soldato argentino Dybala Paulo non diserta e indossa ancora la divisa della pazienza.
Dei suoi ventiquattro anni da predestinato, questo ragazzo dal sorriso gentile ma trattenuto – «Mi sono sentito tradito un’infinità di volte e ho imparato il valore della diffidenza» – sa dire cosa ha inseguito «da bambino, nel posto in cui sono nato, ti mettono un pallone tra i piedi prima ancora di averti dato il ciuccio» e cosa, nella corsa, ha perso.
«Soprattutto la mia adolescenza. I miei amici andavano in discoteca, bevevano birra, fumavano, si ingozzavano senza ritegno e facevano l’alba e io andavo a dormire presto dopo essermi allenato di mattina e di pomeriggio, stando attento a cosa, quanto e quando mangiare. Sono andato via da casa che avevo dieci anni. Nella pensione dell’Instituto de Cordoba, dove sono cresciuto con ragazzi che avevano i miei stessi sogni, si diventava uomini in fretta. Per la prima volta, lontano da casa, senza l’aiuto di mia madre, ero costretto a cavarmela da solo. A rifare il letto, preparare il pranzo, pulire il bagno. Chi mi guarda adesso non può capire cosa c’è stato dietro. Ho avuto la fortuna di poter lottare per un obiettivo, ma io so che non si è trattato di sola fortuna. Non ho vinto un biglietto della lotteria, ma ho faticato, compiuto sacrifici, accettato rinunce, condotto una vita molto sana. Ne è valsa la pena e sono stato ripagato. Ma costruire è difficile e distruggere è semplicissimo. Bastano un paio di cazzate e puoi demolire il lavoro di un’esistenza intera».
Accanto al Lingotto, dove il clan di Dybala (madre, fratello, fidanzata del fratello, amici) si materializza a banchi, all’improvviso, come la nebbia, i palazzi che stingono nella foschia, e che abbracciano l’ex regno della Fiat, raccontano una storia di antica affiliazione. I quartieri operai, la fabbrica e sullo sfondo la squadra di calcio in cui oggi Dybala interpreta il ruolo che all’epoca in cui sul trono sedeva l’Avvocato fu di Michel Platini e, decenni prima, del genio anarchico di Omar Sivori. Uno che con Dybala condivideva i natali e, proprio come lui, correva con i calzettoni bassi, faticava a stare negli schemi e, per smuovere la calma piatta, sollevava un’onda anomala. «Cerco di divertirmi come facevo quando ero ragazzino. Anche se adesso esistono più responsabilità e sul tavolo c’è il mio futuro, non voglio smettere di farlo. Se si stanca la testa, a non girare più sono subito le gambe».
Con l’istinto subordinato alla cerebralità, Dybala è un argentino atipico. Niente del gladiatorio Hugo Gatti, el loco, il portiere provocatore che vedeva piovere rondelle, bulloni e scope dagli spalti e raccogliendo la ramazza, con gusto situazionista, spazzava l’area come se nulla fosse davanti a centomila persone. Nulla della follia di Diego Maradona che palleggiava con le arance e la polvere non la faceva assaggiare soltanto ai propri avversari. Paulo è Paulo. Quello che ha i lontani parenti in Italia e se avesse scelto di cantare l’inno di Mameli forse ci avrebbe portato in Russia: «Mi è stato chiesto di vestire l’azzurro e sono stato molto grato. Avevo 19 anni e rispondere “no, grazie” fu dura. Ma sono argentino e sarebbe stato un inganno». Lo stesso “pibe” che trascorre le ore a edificare le torri del Lego. Legge i libri, ama gli scacchi e a Torino, con una maglia a strisce, ha trovato la sintesi perfetta tra i bianchi e i neri.
Perché gli scacchi?
«Ho imparato a giocare da bambino, con mio padre, prima osservandolo e poi mettendo in pratica quello che vedevo. Lui giocava sempre con i suoi amici, poi ha iniziato a farlo con me. Mi ha insegnato a muovere re, regine e pedoni, anche se non mi faceva vincere mai».
Calcio e scacchi hanno punti di contatto?
«Anche se sembra che non abbiano niente in comune, esistono tanti aspetti che si somigliano. Puoi intuire, pensare e persino decidere come effettuare un colpo in anticipo. Capire come si comporterà l’avversario, leggere i suoi movimenti, sfruttarli a tuo vantaggio. Gli scacchi aiutano a usare il cervello, a non avere fretta. A muoversi armonicamente. Nel calcio accade la stessa cosa. A volte, per prevalere, devi ragionare. Capire a che punto è la partita, conoscere i punti deboli dell’avversario, aspettare la mossa altrui per sfruttare al meglio le tue qualità e le tue forze».
Come ha fatto a diventare riflessivo?
«Non so se sono riflessivo come dice lei o soltanto attento a quello che mi accade intorno. Era così anche a scuola. Non amavo stare in classe, però prestavo attenzione per non dover studiare dopo. Se non ascoltavo o cazzeggiavo – si dice così, no? – poi facevo fatica e per recuperare passavo il pomeriggio sui libri».
Non aveva voglia?
«Nessuna voglia. Guardavo la finestra e mi immaginavo nella piazza del paese, con un pallone tra i piedi. A scuola in realtà sono andato sempre bene. La mia famiglia mi ha impedito di abbandonarla anche quando il calcio sembrava essere diventata la priorità. Quando a Cordoba sono arrivato in prima squadra, mia madre ha litigato con i miei due fratelli che sostenevano dovessi lasciarla: “Stai tranquilla, questa è una grande opportunità”, le dicevano. E lei di rimando: “Lo è anche studiare, soprattutto se a un certo punto in mano non ti resta nient’altro che un diploma”».
C’è stato anche quel rischio?
«Certo che c’è stato. Di ragazzi che avevano un talento immenso, anche più talento di me, e si sono persi senza lasciare traccia ne ho conosciuti tanti. Con alcuni di loro mi sento ancora molto spesso».
Quindi il talento da solo non basta.
«È vero che Dio ci dà un dono, ma poi quel dono va lavorato. Ne ho visti tanti di fenomeni nei settori giovanili. Ragazzi di cui dicevano: “Se solo avesse avuto la testa, avrebbe potuto essere Maradona o Messi”. Ecco, io ho lavorato soprattutto per evitare questo».
Per evitare cosa?
«Che davanti al mio nome ci fosse un condizionale».
Cosa ha marcato la differenza tra lei e i ragazzi che si sono persi?
«Il senso di responsabilità. La passione. Il desiderio di raggiungere il mio obiettivo a ogni costo e di essere pronti a tagliare le radici, se necessario. A Laguna Larga, il paese in cui sono nato, nessuno chiude la porta di casa. Si conoscono tutti. È un piccolo paradiso. Ma se vuoi conoscere il mondo, il paradiso devi essere pronto anche a lasciarlo. Io volevo sfidare le mie insicurezze, conoscere gente nuova, vedere cosa c’era al di là della culla protetta».
Al calcio la instradò suo padre Adolfo. A livello amatoriale, con qualche rudezza, era stato difensore anche lui. L’avevano soprannominato «El chanco».
«In realtà giocava da ala e poi si spostò in difesa. Lo chiamavano “il maiale”, ma in Argentina i soprannomi lasciano il tempo che trovano. Il calcio da noi non è una seconda religione, ma la prima. E monoteista. Se c’è una partita importante si ferma tutto. Se si comincia a parlare di calcio in un bar e due persone tifano per squadre diverse, non è detto che non finisca male. Anche se si è amici. È un sentimento forte, importante, viscerale. Ci sono e ci sono stati altri sportivi importanti, dal tennis all’hockey su prato. Ma il calcio è un’altra storia».
Sulla rudezza di suo padre sorvoliamo?
«Con i miei occhi l’ho visto fare un solo intervento davvero duro. Giocavamo tra adulti e bambini, un avversario più grande di me entrò da dietro per farmi male, papà gli restituì il colpo. Nella vita di tutti i giorni era una persona molto buona. Faceva andare avanti la ricevitoria di famiglia, la Favorita. E intanto trasmetteva a me e ai miei fratelli la malattia del calcio».
Poi ad ammalarsi fu lui.
«È morto per un tumore, quando avevo quindici anni. Fu un dolore fortissimo. Nei mesi precedenti non riusciva più a venirmi a trovare e il club mi fece andare a casa per un po’ di tempo. Sei mesi erano troppo pochi e mi venne la tentazione di mollare tutto. Mi sarebbe piaciuto parlare più a lungo con lui, affrontare una conversazione vera, chiedergli cosa provasse. Ma ero giovane, i miei fratelli volevano proteggermi ed è andata così. Forse un giorno lo ritroverò o forse no, a papà però penso sempre e gli dedico tutti i miei gol. Mi accompagnava con la sua utilitaria da Laguna Larga a Cordoba. Erano 55 chilometri ad andare e 55 a tornare. D’inverno, d’estate, a Natale, a Pasqua. Con la febbre o senza. Solo per farmi tirare calci a un pallone. Non si è mai lamentato, non me l’ha mai fatto pesare».
A lei pesava?
«Finché eravamo insieme, mai. “Domani passi dalla squadra del paese a quella della Capitale”, mi disse. “Sei contento?”. Non dubitai un solo secondo. Ho provato a godermi ogni momento, come facevo da bambino. Il campo di calcio era a pochi metri da casa, ma i miei fratelli avevano dipinto l’ingresso della nostra abitazione con una pietra bianca, disegnando pali e traverse. Ero molto piccolo e non mi ricordo la reazione dei miei, ma qualche vetro l’abbiamo spaccato. Siamo stati gli ultimi».
Gli ultimi a fare cosa?
«A far rotolare una palla per strada e a mettere per terra le felpe al posto dei pali correndo dietro a una palla con le ginocchia rosse fino a quando non faceva buio. Il mio primo computer l’ho visto a 13 anni. E non è che smaniassi per usarlo. Stare a casa per noi significava stare in punizione. Bastava una bici per essere felici».
In Argentina, quando era ancora minorenne, lei divenne famoso per un pianto in diretta.
«Giocavo in seconda divisione con l’Instituto de Cordoba, arrivammo fino allo spareggio per essere promossi in Primera e lo perdemmo. Non avrei voluto piangere, ma non ce la feci a trattenermi. L’Instituto era la squadra che tifavo e alla quale avevo dato tutto fin dai 10 anni. Tra compagni ci eravamo stretti la mano, abbracciati, avevamo fatto un patto. Non bastò».
Si è pentito di quel pianto?
«E perché? Gli uomini piangono. Crollano. Cedono. Ero rimasto a mani vuote e sono crollato anch’io. Mi è venuto e l’ho fatto. Oggi ci penso con tenerezza. E non è stata neanche l’unica volta. Mi è accaduto pure in Nazionale. Giocavamo contro l’Uruguay. Venni espulso. E piansi a dirotto».
L’ultima volta che vedemmo Maradona, prima del controllo antidoping al Mondiale americano del 1994, usciva dal campo con un’infermiera. E rideva.
«Diego è stato grande, ma nel ’94 io avevo un anno. Non è stato un mito del mio tempo, ma è stato un mito. E i miti non hanno bisogno né di morale né di moralismo. C’è a chi piace l’eccesso e c’è a chi piace meno, ma il giusto e l’ingiusto non esistono. Sono categorie relative. Se vedo un compagno con dieci auto di lusso io non lo giudico perché non mi piace valutare gli altri dall’esteriorità. Conta cosa hai dentro. Chi sei dentro. Oggi dei calciatori che stanno sui social pensi di sapere come siano fuori e dentro al campo. Ti illudi di vedere tutto e magari non vedi niente. Ieri li scrutavi solo in tv, ma non è detto che la lettura fosse più parziale».
Come nel Mondiale del 1978. In piazza le tv mostravano le immagini degli argentini in festa. Nel sottosuolo gli oppositori del regime di Videla venivano torturati e fatti sparire.
«È una storia che conosco. Una storia amara. So cosa è accaduto, ho letto, ho visto le immagini, i film, i documentari. Chi festeggiava non sapeva, chi sapeva attraversava bruttissimi momenti».
Cosa è per lei la libertà?
«Essere come si è senza temere il giudizio di nessuno. Vorrei essere concreto e farle un esempio, ma forse la libertà è esattamente non rispondere a questa domanda».
Si sforzi.
«Farsi capire da tutti è difficile. Spesso la tua libertà e la tua opinione non coincidono con quello che la gente vuole sentirti dire o che i giornali vogliono attribuirti per forza. Se sei noto, comunque, avere la struttura per sopportare le critiche è un criterio indispensabile per sopravvivere».
Come si controllano le emozioni?
«È una delle imprese più difficili che esistano. Tante volte mi è capitato di non riuscirci. Credo per mancanza di esperienza, soprattutto. Miglioro piano piano».
E l’ambizione invece cos’è?
«Svegliarsi ogni giorno con un obiettivo in testa e cercare di raggiungerlo. Avere la capacità di accontentarsi del passo corto e non pretendere di volare. Sapere che ti migliori solo se non smetti di provarci».
Chi diventa davvero un calciatore, quando arriva al suo livello?
«Il più delle volte un uomo molto solo. Come le dicevo prima, le cose negative che ti accadono restano. E lasciano un segno. Per questo sono diffidente e per questo mi riesce difficile credere e avere totale fiducia nelle persone».
Le sembra bello?
«Mi sembra bruttissimo. Essere duri, indurisce. Essere aridi, inaridisce. E se giudicare è complicato, giudicare senza conoscere è impossibile».
Come si tutela?
«Mi sforzo di non avere pregiudizi, ma è difficile. Anche con le ragazze. Penso sempre che almeno il 90 per cento di loro non si avvicini a me per amore o per il mio bel faccino, ma per altro».
Per cosa?
«Magari per approfittare della notorietà e ottenerne a sua volta. So che è triste dirlo, però è la verità. Il mio è un mondo in cui devi stare attento a molti aspetti, in cui se non guardi con attenzione alle cose soffri molto più di quanto tu non goda. Per questo dico ai bambini, godetevi il gioco finché resta tale. Dopo cambia. Cambia inevitabilmente».
Non sembra una fotografia felice.
«Quando abbiamo un pallone tra i piedi, noi calciatori siamo felicissimi. Quello che succede dietro, nel retropalco, spesso non è proprio bellissimo».
Lei vuole vincere il Pallone d’Oro.
«È vero. Quando ci riunivamo intorno al fuoco, da bambini, d’estate, espressi quel desiderio con i miei amici».
È stato lei a capire di aver talento o gli altri a convincerla che ce l’avesse?
«Sono stati gli altri. Non avrei mai immaginato di raggiungere quello che ho raggiunto, però ora sono consapevole che posso raggiungere qualsiasi traguardo».
Ma un Pallone d’Oro non è solo un trofeo che quando non giocherà più resterà soltanto un oggetto da spolverare in bacheca?
«Vincerlo sarebbe un messaggio importante per tanti bambini. Per tutti quelli che nati in un piccolo posto lontano dai grandi centri – calciatori, medici, ingegneri o poeti che siano – possono sperare di poter raccontare una storia simile alla mia».
Cosa insegna la sua storia?
«Che per quanto ti smontino, ti buttino giù o ti dicano “è impossibile, non ce la farai mai”, niente è veramente impossibile».
Fonte. Vanity fair autore Malcom Pagani